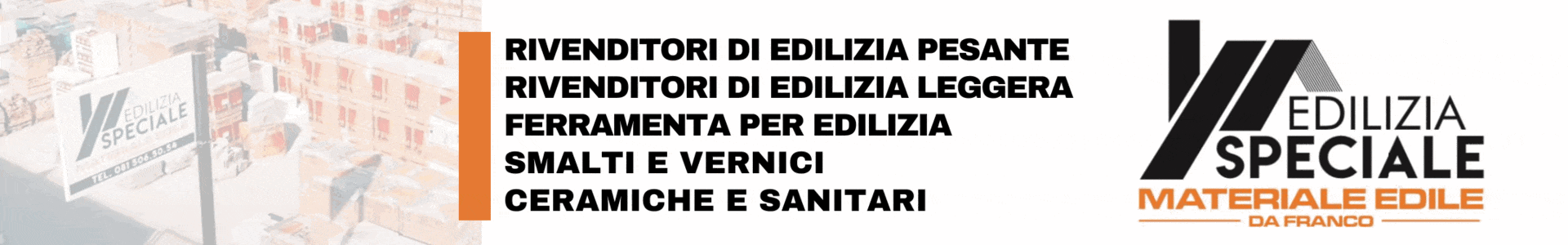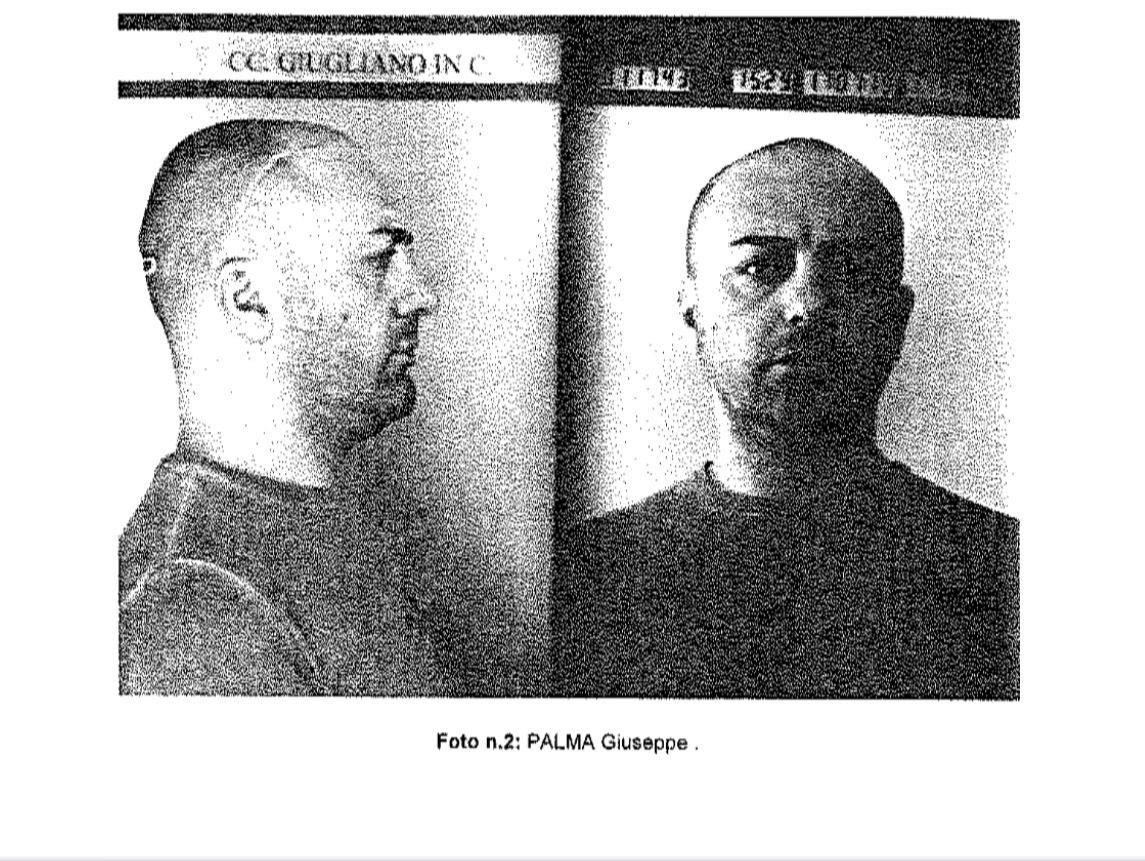Si chiama Andrea Serrani. Ha 45 anni, una compagna e una figlia. Nella vita fa l’imprenditore. E’ questo l’identikit del molestatore televisivo che ha assestato un pacca sul sedere di Greta Beccaglia, la giornalista di Toscana Tv diventata protagonista involontaria di una vicenda mediatica talmente gonfiata da risultare farsesca. L’uomo dovrà rispondere di violenza sessuale. Rischierebbe, codice penale alla mano, sette anni di carcere.
Pacca sul sedere della giornalista Greta Beccaglia, fermi tutti: stiamo esagerando
L’episodio in questione ci dà alcune lezioni su cosa sia diventata la società di oggi. La prima è che qualsiasi cosa, per acquisire statuto di realtà, necessita di un’esposizione pubblica. La sindrome dell’homo videns spinge voyeuristicamente le persone a prestare attenzione a un fatto solo se è documentato da una telecamera o da un telefonino. Solo, in sintesi, se trasformato in immagine.
Ogni giorno ci saranno – a telecamere spente – manate assestate sul fondoschiena di tantissime donne. Tutte vittime di un gesto odioso e retrogrado. L’operaia palpeggiata dal suo datore di lavoro; l’avvocato praticante molestata dal suo dominus. La commessa stalkerizzata dal commerciante sposato. Nessuno se ne cura. Fanno parte della triste sequenza quotidiana di violenze sulle donne confinate, nel migliore dei casi, ai trafiletti di cronaca locale solo perché il sistema mediatico e il suo pubblico respingono tutto ciò che non è visibile.
Questo meccanismo di decostruzione della realtà finisce per dirottare l’attenzione su episodi minimi, oscurando fatti ben più gravi che spesso sono l’anticamera di femminicidi e maltrattamenti fisici. Il gesto di Andrea Serrani è solo la punta dell’iceberg. E l’iceberg è quel residuato subculturale maschilista che ancora sopravvive in ampie sacche della nostra società e che considera la donna un oggetto da toccare, mortificare, usare a proprio piacimento. “Non sono un violentatore”, ha detto Serrani. E c’è da credergli: possiamo essere in buona fede. La sua storia personale parla chiaro. Probabilmente non ha mai usato violenza su una donna.
Da condannare? Senz’altro. Ma non occupiamoci (solo e soprattutto) di una pacca sul sedere. Ripristiniamo il buon senso e la scala delle priorità nella lotta alle violenze di genere. Documentiamo gli insulti sulla compagna del nostro amico, denunciamo il vicino che picchia la moglie, picconiamo il muro di omertà che troppo spesso protegge i maschi violenti dalla legge e condanna la donna a subire violenze fisiche e psicologiche fuori e dentro le mura domestiche.
Maschilismo a intermittenza? No alla mercificazione del corpo a lavoro
La seconda questione che solleva questa storia è altrettanto importante, ma più densa di implicazioni culturali e di più difficile lettura perché si presta facilmente all’equivoco. E riguarda la mercificazione volontaria e consapevole del proprio corpo da parte delle donne nel mondo del lavoro. E’ una questione collaterale, che chiama però in causa la stessa subcultura maschilista che ha animato il gesto di Andrea Serrani. Una faccenda spinosa, impopolare, perché poco amata dagli apostoli del politically correct, pronti a trasformare sempre e comunque la donna in vittima, anche quando le donne sono vittime di se stesse.
Mi riferisco ad alcune professioniste – giornaliste per lo più sportive, avvocati, stagiste, piccole imprenditrici – che ostentano il proprio corpo per farsi strada nel mondo del lavoro. Che indossano tubini e abiti succinti o adottano pose provocanti in contesti dove il sesso e l’ammiccamento sono fuori luogo. E non lo fanno – spesso e volentieri – con ingenuità, ma consapevolmente, perché sanno bene che possono usare le proprie doti estetiche per trarne vantaggio e costruirsi un pubblico maschile pruriginosamente attento ai décolleté generosi o alle gambe più sode. Per farsi un’idea, basta aprire un social, in particolare Instagram. I profili sono migliaia. Alcuni sono economicamente redditizi. Donne di ogni estrazione sociale che speculano abilmente sulle proprie forme per costruire un’immagine sessualmente compiacente e maliziosa da impiegare per fini lavorativi.
E quindi, mi si dirà, significa che le donne non possono vestirsi liberamente in ufficio? Che la rivoluzione dei costumi sessuali dagli anni ’60 in poi non ci permette di indossare una minigonna? Certo che no. Però basta con le ipocrisie: la donna non si presti ad essere un oggetto di desiderio sessuale sui luoghi di lavoro. Non mercifichi il proprio corpo in una trasmissione sportiva per interrompere lo zapping dei telespettatori, non si faccia un selfie gonfiando le labbra mentre si trova in tribunale per conquistare clienti/follower sui social, non mostri il seno al responsabile delle risorse umane per ottenere un posto in azienda durante il colloquio di lavoro. Questi comportamenti sono l’altra faccia della stessa subcultura maschilista che le femministe più agguerrite vogliono sopprimere. Anzi: l’alimentano. Il maschilismo, invece, è una piaga che va combattuta su ogni fronte. Non a intermittenza. Anche quando i retaggi di quel mondo fanno comodo e permettono di trarne benefici economici o professionali.